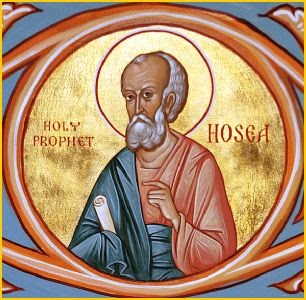Il progetto di Dio sulla coppia viene disatteso dall’uomo e la coppia conosce l’elemento dell’infedeltà. Non faccio questo discorso soltanto per convincerci di una cosa ovvia, cioè che l’uomo non è poi così capace di amare per sempre come sembra; ma per vederlo da un altro punto di vista, come una specie di appello provocatorio su quello che deve essere l’amore che si rivela proprio nel momento in cui viene messo in crisi. Il Nuovo Testamento, nel discorso che porta a compimento la Rivelazione sull’uomo, dice che la coppia, lo sposo e la sposa, diventano segni dell’amore che Cristo ha per la sua Chiesa, segno dell’amore che Dio ha per gli uomini. La coppia dovrebbe amare come Dio ama, perché deve essere segno dell’amore di Dio.
Ora, in che modo Dio ama lo si vede soprattutto nel momento in cui il suo amore viene rifiutato. Osea 2 tratta appunto di questo: è il grande testo di accusa contro il popolo infedele, fatto attraverso la figura del profeta che accusa la propria moglie di infedeltà.
La moglie infedele
Leggendo il testo di Osea 2 ci troviamo davanti ad un amore che, da parte dell’uomo, non è segno di nulla, anzi è segno di infedeltà, e da parte di Dio manifesta, nel momento della crisi, la vera capacità dell’amore. L’amore si misura proprio dalla sua capacità di arrivare fino in fondo. E’ nel momento della crisi che si rivela fino a dove l’amore riesce a resistere. Dunque, è proprio davanti alla donna infedele che si rivela fin dove Dio è capace di amare.
Osea è chiamato, nella sua vicenda personale, a rivelare, presso il popolo, il volto di Dio. La vicenda personale di Osea è quella di essere sposato ad una donna “di prostituzione”. Non si sa bene in che modo questo debba essere interpretato: si può andare da un’interpretazione letterale fino alla posizione più tenue che vi vede solo una finzione profetica.
Forse la verità sta nel mezzo, e si può pensare che davvero Osea abbia vissuto una vicenda matrimoniale difficile con una donna che non necessariamente era una prostituta, ma che semplicemente era una donna di Israele, cioè una che faceva parte di un popolo infedele a Dio, incapace di rimanere nell’amore. Osea sposa una donna di quel Popolo che dovrebbe essere “sposa” del Signore e che invece si sta prostituendo con gli idoli.
La situazione è perciò quella di un profeta chiamato ad entrare nella realtà del popolo così come è. Il profeta, mediatore della verità di Dio presso il popolo, è chiamato ad entrare nella realtà in mezzo a cui deve essere segno. Non si deve separare, ma deve compromettersi al punto tale da sposarla.
Questo è importante per capire il modo con cui noi ci si deve rapportare alla realtà. Questo fa capire meglio cosa faceva Gesù portando a compimento questa rivelazione d’amore. Ciò che viene chiesto al mediatore di Dio è l’impegno “per sempre”, è la capacità di rispondere con la fedeltà all’infedeltà, di rispondere con l’amore al tradimento entrando nella situazione di tradimento.
E’ l’amore che entra nel peccato, non per diventare tradimento anch’esso, ma per trasformare quel tradimento in amore. Questo è ciò che è chiamato a fare Osea. E come lui, ogni coniuge, ogni uomo.
L’accusa
Osea, a nome di Dio, rivolgendosi alla sua donna, si rivolge a tutto il popolo. Inizialmente accusa questo popolo. Il popolo sta peccando perché si è allontanato da Dio. Cosa deve fare il profeta? Accusare, rendere esplicito, verbalizzare, portare alla luce il peccato dell’altro: “Accusate vostra madre, accusatela perché non è più mia moglie e io non sono più suo marito” (Os 2,4).
Nella Bibbia, l’accusa è sempre presentata come “mediazione di perdono”, perché ha come unico scopo di aiutare il peccatore a capire che quello che sta facendo è sbagliato, non ha senso, gli fa male. L’accusa non è il modo con cui si inchioda l’altro alle sue responsabilità. Non è un modo con cui si rovescia sull’altro il peso del suo male ma, anzi, è un modo con cui, per amore, con l’amore, si aiuta l’altro a capire che ciò che sta facendo è male, così che possa smettere di farlo e tornare ad essere in comunione. L’accusa biblica e poi, in modo più esplicito, l’accusa cristiana, è la parola che viene da colui che ha già perdonato; non avviene che prima si accusa e poi, se l’altro accetta, si perdona. Prima si perdona e poi, mossi dall’amore per l’altro, da questo perdono già dato, da questo desiderio di vita e felicità per l’altro, si va ad aiutarlo a capire quello che sta facendo perché smetta di farlo. L’unico interesse dell’accusa non è togliersi una soddisfazione, né l’amore astratto per la giustizia. L’unico scopo è che l’altro sia di nuovo felice, sia salvo: questa è l’accusa di Dio, a questa siamo chiamati.
Il profeta Osea deve perciò accusare la donna perché capisca il male che sta facendo, e prenda coscienza di ciò che ha provocato: “Essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito”. Non è questa una rivendicazione dello sposo, ma un modo con cui lo sposo dice ciò che la sposa ha già creato con il suo comportamento. Perciò: “Accusatela e lei – ecco lo scopo dell’accusa – si tolga i segni delle sue prostituzioni.” Scopo dell’accusa è la salvezza. “Altrimenti – dice il testo – la spoglierò tutta nuda, la renderò come nacque, come terra arida, la ridurrò a un deserto e la farò morire di sete” (Os 2,5).
Si comincia a vedere come è l’amore di Dio e come è l’amore che deve muovere l’uomo. L’amore di Dio è tale che, volendo portare l’altro alla salvezza, lo accusa perché si converta e quando anche l’altro non fosse capace o non volesse, interviene con qualche cosa che apparentemente è punizione, ma in realtà è offerta di salvezza. Infatti, la minaccia di denudare la sposa fa riferimento alla punizione infamante che si riserva in Israele alle adultere, e che faceva seguito alla condanna. Ma nell’amore di Dio questa punizione è salvezza, perché è con essa che Dio di fatto toglie di dosso alla donna quei segni di prostituzione che lei non è capace di togliersi e che la condannano. L’intervento di Dio è sempre di purificazione; è per salvare l’uomo, non per condannarlo.
Il vero amore e il vero perdono – dice la Bibbia – si preoccupa che l’altro sia salvo, buono, felice. Se io semplicemente dico: “Lasciamo perdere…”, non mi sto più interessando della salvezza dell’altro. Sto mentendo sul peccato, perché sto facendo come se non fosse una cosa orrenda, inaccettabile, che provoca l’ira di Dio. Il perdono non è la menzogna che dice che il peccato non è grave. Il perdono invece manifesta fin in fondo l’orrore del male, perché anche l’altro, provandone orrore, possa smettere di farlo.
Il perdono è portatore di verità. Senza verità non c’è salvezza. La punizione è necessaria perché si manifesti fino a che punto di capacità di morte arriva il peccato. Serve a dire che il peccato uccide. Solo che nel momento in cui dice che il peccato uccide – questo è il miracolo del perdono di Dio di cui l’uomo deve farsi portatore – pone le premesse perché l ‘altro invece possa vivere. Non inchioda l’altro a quella morte, ma gli apre la strada perché da quella morte possa uscire.
“La renderò un deserto, la spoglierò nuda”. Questo è un modo con cui la sposa fa esperienza di una morte che lei stessa si è provocata. Tutto questo perché per lei possa essere possibile aprirsi a quel dono di vita che è il perdono dello sposo. “E la farò morire di sete”. La punizione è la manifestazione del peccato stesso dell’uomo: questa donna, questo Israele, si prostituiva, andando dietro a Baal, dio della pioggia, della fertilità. La sete serve così a smascherare l’inganno: la donna andava dietro a Baal per averne pioggia e fertilità, ma è invece Dio l’unico Signore della vita. E la sete rivela che la vita non può venire da Baal. Con la punizione, l’altro si libera dal peccato capendo l’inganno.
Infedeltà e prostituzione
Il testo procede poi affermando che i figli di questa donna non possono essere amati e che essa va dietro ai suoi amanti per averne delle cose: “Seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, il mio vino, il mio olio, le mie bevande.” (Os 2,7). E poi: “Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti” (Os 2,14). Cos’è questo discorso del dono? Dio dice: “Allora ecco, io mi riprendo i miei doni”. Proviamo a pensare un momento: cos’è la prostituzione? Cos’è l’adulterio?
E’ un modo con cui un rapporto, che dovrebbe essere unico, si spezza per diventare molteplice. La donna di Osea, invece di avere Osea per marito, ha gli amanti. Quindi, il suo rapporto entra in una dimensione di molteplicità. E’ quasi una specie di “imitazione perversa dell’amore”. Nel rapporto coniugale, l’unione dei due corpi significa l’unione delle persone, dei cuori, delle vite: “I due diventeranno una sola carne” (Gen 2,24). C’è questo dono talmente totale che io ormai non mi possiedo più, sono diventato uno con l’altro, indissolubile; ormai siamo una cosa sola. Il rapporto sessuale è manifestazione e segno di questo. Quando invece si entra in una dimensione di adulterio e prostituzione, il rapporto corporeo non può più essere segno dell’unione del cuore, perché l’unione suppone che i due siano uniti e che non ci sia più possibilità di staccarsi, riprendersi il dono e darsi a un altro. La molteplicità, di sua natura, nega il dono. Il dono di sé non può essere altro che totale. Se la donna è di tutti, vuol dire che non è più di nessuno.
Questa molteplice che nega l’unicità tipica del matrimonio, fa sì che il rapporto di unione perda anche la sua dimensione di fecondità. Perché quando anche i figli nascessero, non sono più il prolungamento di quell’unica carne che sono i due che si sono uniti, perché dove c’è molteplicità di padri, non c’è paternità possibile.
Inoltre, nel rapporto d’amore i doni esprimono quell’amore, diventano manifestazioni di quel dono di sé che è il vero dono che conta. I doni materiali sono solo un segno, una memoria; per questo noi diciamo che tanto più sono piccoli, tanto più sono importanti. Non sostituiscono il dono di sé, ma lo segnalano. Nel rapporto di prostituzione, invece, quando ciò che si cerca sono i doni, succede che questo segno, tipico della relazione matrimoniale, si perverte perché i doni non esprimono più amore, offerta di sé, ma diventano invece merce di scambio. Comprano il corpo, diventano luogo di possesso. Si dà se stessi in cambio del dono, invece di dare se stessi dando il dono.
L’idolatria
Nel nostro testo, il fatto di avere gli amanti, è un segno del fatto religioso di entrare in una dimensione idolatrica. L’idolatria è entrare in un rapporto religioso e cultuale con Dio nel quale si cercano i doni invece di cercare solo il donatore.
L’idolo è tutto ciò che si sostituisce a Dio: l’ideologia, i nostri bisogni, ciò che noi identifichiamo con la nostra felicità o con la nostra vita, il denaro, la salute, una persona, la carriera, tutto ciò che da relativo viene trasformato in assoluto.
Siamo idolatri ogni volta che pensiamo che la vita nostra si realizza non nel rapporto con Dio, ma con ciò che non è Dio. Addirittura l’idolo può essere la nostra stessa idea di Dio. Ogni volta che chiudiamo Dio nei nostri schemi e diciamo che dovrebbe agire in un certo modo, ogni volta che gli diamo contorni fatti a nostra misura, stiamo facendo un idolo, siamo quegli stupidi che si fanno statuette e dicono: “Tu sei mio padre!”
Ognuno di noi ha degli idoli personali da smantellare. Addirittura la vita spirituale può diventare idolatria. Se crediamo di essere noi a costruire, meritare, ad acquistare la salvezza con il nostro essere buoni, con le nostre opere, con i nostri meriti, sforzi, fatiche, fedeltà… Ogni volta che facciamo così, siamo come la prostituta di Osea che va dietro agli idoli perché vuole il suo vino, la sua lana, il suo olio.
Che cos’è l’idolo? E’ Dio fatto a mia misura che mi dà ciò che chiedo. Questa è la comodità dell’idolo: faccio il sacrificio e poi sono sicuro che lui mi dà quello che chiedo. Ebbene, ogni volta che noi, per il nostro bisogno di rassicurarci, costruiamo da noi la nostra salvezza, invece di accoglierla come dono totalmente gratuito, noi entriamo in una dimensione idolatrica.
Cercare rassicurazione, certezze, è tipico dell’uomo. Il problema, con Dio, è che la certezza sta in Lui e non in noi. La vita eterna è già stata donata, e noi siamo certi che Lui ci salva, però questa certezza si basa sul fatto che ci fidiamo di Lui. E’ la gratuità che spiazza, non abbiamo delle cose nostre su cui appoggiarci e dire: “Ho accumulato questo numero di meriti e adesso sto tranquillo!” Ma bisogna appoggiarsi sull’invisibile Dio della cui bontà siamo certi, ma la cui fedeltà si appoggia solo su Lui e su niente che noi possediamo. Allora cerchiamo gli idoli.
La rivelazione del donatore
Che cosa dice il testo di Osea? Quando è così, Dio interviene e rende tutto un deserto. E’ il vero donatore che si rivela. Dio prende tutti i doni di Baal perché la donna capisca che l’unico dono viene da Lui e che ciò che conta è il rapporto con il Donatore e non con i doni.
Quando c’è il rapporto con il donatore, i doni vengono, ma non viceversa. Allora il donatore si rivela: “Riprenderò il mio grano”, e ritorna l’immagine della desolazione: “La ridurrò ad una sterpaglia, le farò scontare i giorni dei Baal, quando bruciava i profumi” (Os 2,5). Torna l’idea della spogliazione. L’intervento punitivo di Dio mette l’uomo in una situazione di totale nudità, cosicché possa finalmente capire quali sono i doni davvero importanti che fanno vivere e, soprattutto, da chi vengono. Il cammino dell’assenza di Dio, il cammino della morte, è una riscoperta del Dio della vita. Infatti, a questo punto del testo, Dio si rivela come Dio della vita: “Lei seguiva i suoi amanti e dimenticava me, perciò – ecco la conseguenza sorprendente! – io l’attirerò a me e la sposerò”.
Questa è la logica di Dio. Questo è il modo con cui l’amore di Dio giunge fino alla fine. La grande novità dell’operare di Dio che riporta alla vita la donna facendola passare per una morte che è riscoperta della vita.
“La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore”. L’immagine del deserto nella Bibbia è ambivalente, perché, da una parte, è il luogo in cui Israele ha imparato a vivere di fede, è un momento privilegiato per capire chi è Dio. D’altra parte, tutto questo è avvenuto nella tentazione costante di abbandonare Dio, in un’esperienza dura e faticosa. Il deserto è il luogo idilliaco dove Israele ha scoperto chi è Dio, ma è anche il luogo tremendo dove Israele continuava a dire che Dio non c’era perché si guardava intorno e c’era il nulla. E’ difficile scoprire che Dio è buono quando intorno a sé si ha solo la morte. Eppure, questa è l’esperienza del deserto: entrare in questo luogo di morte, dove c’è il nulla, per scoprire veramente tutto, scoprire che il tutto di cui si ha bisogno è Dio e non le sue cose.
E’ il luogo dell’assenza, per scoprire la vera presenza. E’ il luogo della mancanza delle cose, per capire invece il rapporto vero della persona.
Quando è così, la morte si trasforma in vita, il deserto diventa vigna; la sposa, da prostituta che era, diventa vergine. La donna che seguiva i suoi amanti diventa colei di cui Dio dice: “Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore” (Os 2,21-22). Lì dove il perdono di Dio si offre all’uomo, in cui l’uomo semplicemente accetta questo perdono, l’uomo è ricreato nuovo, rifatto santo.
Girolamo commenta così il nostro testo: “Ecco l’unione tra Dio e gli uomini: l’uomo, quando prende una donna, da vergine che era, la rende donna (cioè non più vergine). Invece, quando Dio si unisce anche a delle meretrici, le trasforma in vergini”.
Questo è l’amore. Questo è il miracolo dell’amore di Dio che gli uomini sono chiamati a vivere e a riprodurre nella loro relazione coniugale e anche con i propri fratelli. Agli uomini è chiesto un amore che sia segno di questo modo con cui Dio ama. Alla coppia è chiesto un amore capace di entrare anche dentro l’infedeltà per trasformarla in fedeltà di vergine. Alla coppia è chiesto un tale dono di sé da poter portare la pazienza del proprio amore fino alla fine, fino al segno che Osea rivela con la sua sposa e che nel Signore Gesù viene definitivamente portato a compimento: un amore capace di dare la propria vita per coloro che vogliono ucciderlo.