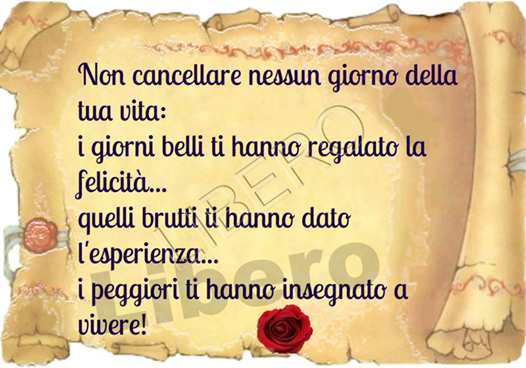«Sono convinto che solo attraverso un approccio multidisciplinare, dialogico, orientato al progresso ma anche alla salvaguardia della dignità umana, si possa affrontare questo difficile momento storico, guardando con speranza al futuro»: le parole del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, scritte a introduzione del volume «Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19» (Cnr Edizioni, Roma, 2020) esprimono il senso del lavoro condotto in queste settimane dalla Consulta scientifica del Cortile dei gentili, presieduta da Giuliano Amato. L’organismo ha infatti condotto al suo interno un confronto aperto e articolato, che trova un naturale collegamento con la presente rubrica de «L’Osservatore Romano», condividendone i fini e le istanze iniziali. Il volume, che, curato da Cinzia Caporale e Alberto Pirni, ruota attorno al documento che gli dà il titolo, è una raccolta di contributi scritti con la volontà di “portarsi oltre il primo atto della crisi determinata dal contagio del nuovo coronavirus”. Scrive nella prefazione Giuliano Amato: «Sono molte le proposte che avanziamo perché questi fini siano realizzati e siamo lieti di constatare che per diverse di esse siamo tutt’altro che soli. Qui ne segnalo solo una, che è quella che abbiamo tratta dell’esperienza appena conclusa. Nei lunghi giorni che abbiamo passato chiusi in casa, con uscite contingentate e imparando a indossare la mascherina per incontrare gli altri, abbiamo anche imparato quanto il coordinamento di tante piccole scelte individuali possa contribuire al bene comune. È un insegnamento da conservare e da praticare su larga scala per il futuro». Fra i diversi interventi raccolti nel volume, «L’Osservatore Romano» pubblica oggi, quello intitolato «Riflessioni sul futuro». Nei prossimi giorni verranno pubblicati, d’intesa con il Cortile dei gentili, altri contributi.
“Nulla sarà come prima” e davvero “ne usciremo migliori”? La lezione della Storia — come si usa dire — non ci dice questo, ma ci indica piuttosto il rischio di uscirne peggiori. O con gli stessi vizi se non avremo visione e tanto pragmatismo. La difesa della terra comune, l’appello della Laudato si’, il sentirci più uniti in un unico destino planetario, pronti all’empatia e alla benevolenza, tutto ciò sarà molto difficile da comprendere per chi deve combattere con la miseria materiale, la solitudine e il degrado sociale. Per esperienza esistenziale e spirituale siamo profondamente convinti che ex malo bonum; “dal male può uscire il bene” non è però un assioma deterministico, come argomentava lo stesso s. Agostino: il male fa venire fuori il bene solo se “ci si lavora”, con consapevolezza. E lo sforzo volontaristico, pur necessario, non sarà mai sufficiente. Come quando attraversiamo una grande malattia, così questo virus sta funzionando da reagente chimico: esalta, accentua, “fa venire fuori” l’essenza di quello che, al fondo, è quella specifica persona, quella comunità, quella nazione. E lo stesso approccio o linguaggio bellico, quello dell’attaccare, resistere, sconfiggere, sopraffare, sono inadeguati. Non abbiamo sofferto la fame né avuto il terrore delle bombe sulla testa, come nelle guerre, né proviamo il grande sollievo per la fine di quella minaccia, che portava speranza e voglia di ricostruire sulle macerie con progetti per il futuro. Noi, invece, dovremo convivere con questa paura strisciante che ha diviso il Paese e le sue regioni già durante la pandemia; la porteremo dentro, bisognerà elaborarla nel tempo. Non sarà un evento isolato, non sarà un “cigno nero”.
Del resto dalle pandemie come dalle guerre mondiali (solo in questo uguali) non si è mai usciti migliori di prima. Pensiamo alla Grande Guerra, vero spartiacque del Novecento, secolo breve perché lì iniziò, con la fine dei grandi imperi e la scoperta di una soggettività fragile nella sua ambivalente ricerca di un’identità. Il primo dopoguerra ebbe così un carattere vitalistico-onnipotente-depressivo, gli anni Venti si fondano dunque sul rancore rivendicativo placato nei totalitarismi, che incanaleranno la “modernizzazione” in una versione autoritaria, fino a quando i nodi irrisolti della prima guerra, sopiti nel periodo entre deux guerres, esploderanno nella seconda. Ed è a questo secondo dopoguerra che molti guardano come possibile modello per il dopo covid-19. Allora la spinta ricostruttiva era affidata a fattori assai meno patologici rispetto al primo dopoguerra, ovvero alla forza che derivava dall’unità di tutti contro il nemico comune, almeno fino al 1947. Con la guerra fredda questa “energia unitaria” si tradusse rafforzandosi nella delegittimazione di un campo contro l’altro, cementando le due identità, quella collettivista e quella capitalista. E la società visse in pieno queste speranze, sul piano soggettivo, nella famiglia e nella crescita demografica, e, sul piano delle nazioni, nella comune volontà di non ricadere nella terza guerra mondiale. Tutto questo reso possibile dal decisivo aiuto americano. Un piano Marshall, quello vero. C’erano una visione, un progetto, un’idea di futuro. Sapremo ritrovarlo o sprofonderemo nelle enormi fragilità in cui il nuovo coronavirus ci ha sorpresi?
I nostri vizi
Le due novità assolute di questa pandemia, sia rispetto alle guerre mondiali sia alle pandemie precedenti, sono il suo carattere davvero “globale-universale” e la comunicazione-informazione ormai “globale-capillare”, con conseguente controllo sulle nostre vite. La radicalità della sfida è dunque enorme e forse anche per questo rischiamo di oscillare ancor di più tra due visioni estreme: quella “altruistica” e quella “cinica”.
Proprio perché ci piacerebbe molto che l’esito fosse quello di una resilienza trasformativa cerchiamo però di non confondere il desidero con la realtà e dunque diffidiamo delle aspettative palingenetiche: sono ingannevoli i toni aulici che sentiamo spesso intorno a noi. Le nostre bussole per il futuro, ovvero sussidiarietà, cultura, connessioni, formazione e senso di responsabilità, saranno sempre più necessarie solo se adeguate a un contesto tanto diverso e non potranno essere riproposte semplicemente come alternative a un mercato senza controllo, per inseguire una “decrescita felice” in contrapposizione alla globalizzazione. Abbiamo ormai capito che uno sviluppo sostenibile ha bisogno di più ricerca, più tecnologia, più competenze. È dunque alla formazione di una nuova classe dirigente che bisogna pensare, non come un mantra troppe volte ripetuto, ma come necessità ormai prioritaria. Senza illusioni dobbiamo adoperarci insieme a uomini e donne di buona volontà per aiutare l’azione pubblica, bloccata e incapace di decidere secondo una visione maldestra nella gestione. E dobbiamo riprendere un cammino riformista virtuoso in un mondo che sarà altro. Perché il rientro dall’incubo del contagio ha già rivelato i nostri vizi, ed esasperato i nostri limiti: l’assistenzialismo nella varietà infinita dei contributi lanciati a pioggia, il corporativismo nella frammentazione disarticolata dei sussidi, il burocratismo nella quantità e nella farraginosità dei provvedimenti, la mancanza di gestione nella lentezza e nell’incompetenza, la distanza dal Paese reale, il giustizialismo populista e illiberale nel controllo della fase di chiusura e, dulcis in fundo, l’incombere della magistratura come supplenza delle scelte politiche. Mali che si riversano anche nel nostro rapporto con l’Europa che vediamo alternativamente nelle vesti o di madre benevola o di matrigna crudele: tutti ossessivamente concentrati su quanti soldi siano disponibili (e certo ce ne vogliono tanti e con condizioni non capestro, chiare o occulte) ma con poca cura su come spenderli. Nessuno che ricordi come non siamo stati ancora capaci di spendere i fondi europei già utilizzabili da anni!
Le nuove discriminazioni
Le diseguaglianze e l’impoverimento cresceranno in uno svantaggio che non sarà “solo” economico: una disparità che intacca la dignità stessa delle persone perché vecchie, ammalate, sole. Gli anziani come metafora dello “scarto”. Sarà difficile da onorare in concreto, fuori dalla retorica, quel rispetto per la risorsa formativa che avrebbero gli anziani, riscoperta a parole, per il senso di colpa della strage da covid-19. Le donne rischiano di essere ancora più penalizzate, sia sul piano delle condizioni lavorative, sia nei ruoli (per il carico doppio e triplo di lavoro, per la presenza sempre più essenziale che la donna avrà nei difficili equilibri familiari, nella formazione dei figli che tornerà in gran parte sulle sue spalle). Il concetto di generatività, in senso lato, sociale ed economico, che ci è tanto caro, non può distrarsi dal suo carattere originario e letterale, cioè non può farci dimenticare il generare primario, quello di generare figli. Se da anni le donne avevano smesso di fare figli, diventa prioritario invertire, nel futuro, questa devastante tendenza: creare le condizioni materiali e relazionali per procreare deve diventare una sorta di “diritto umano” fondamentale. Sappiamo che il lavoro femminile non solo non è in contrasto con la maternità, ma che anzi, nei Paesi dove le donne sono più occupate, il tasso di natalità cresce per tante ragioni, economiche, psicologiche, relazionali. La donna e la maternità erano penalizzate già prima di covid-19 e ora rischiano di tornare a un modello familiar-femminile anni Cinquanta, più nel male che nel bene: senza quello slancio procreativo e senza l’energia del lavoro femminile fuori dalle mura di casa.
Tutti a leggere Edward Snowden
La tracciabilità, la crescita del controllo sulle vite private non più solo del mercato e dei privati ma dello Stato ci fa ripensare “quale libertà” ci aspetta nel futuro. Il digitale, sempre più indispensabile (e speriamo esteso ai ceti più poveri) ripropone i margini dell’autonomia del “cittadino-suddito” rispetto al “Potere”. Oltre allo storico e scienziato Frank Snowden, che aveva allertato sul rischio epidemia mondiale, da ultimo nel 2019, citato da Stefano Zamagni nel saggio contenuto in questo volume, molti, nei giorni del lockdown, hanno letto anche un altro Snowden, Edward, il famosissimo informatico americano che aveva alzato il coperchio del vaso di Pandora della nostra totale tracciabilità. Viviamo già in una società “sorvegliata” (attraverso Google, Facebook e soprattutto i nostri iPhone) e con la tracciabilità a scopi sanitari ci saranno ancora nuovi rischi per la privacy e la libertà. Prima avevamo un’idea sterminata dei confini della libertà. Occorrerà tornare alla radice dei diritti umani. La richiesta indistinta dei diritti era cresciuta esponenzialmente, alimentata quantitativamente in una pletora di rivendicazioni spesso senza distinzioni e priorità. E sostenute dal desiderio individuale, da quella dilatazione delle soggettività e della libertà sganciata dalla responsabilità, per cui ogni desiderio diventava un diritto. In una dimenticanza dei doveri denunciata ormai dalle coscienze più avvertite anche nel mondo liberale e da ambienti tutt’altro che conservatori e bacchettoni. Quello dei diritti non era già più da molto tempo un tema divisivo tra laici e cattolici, ma riguardava tutte e tutti perché allude a una comune visione antropologica. In questa sorta di dirittismo si avvertivano dunque pericoli che oggi si presentano prepotentemente, la prima questione è la separazione-scissione tra diritto individuale e diritto sociale e la seconda la tutela della dignità delle persone. Libertà individuali e giustizia sociale devono andare insieme. E perché questo possa accadere è fondamentale avere una visione positiva della comunità. Uscire cioè da un orizzonte solo individualistico. Ma senza idealizzazioni: la famiglia non è quel paradiso vagheggiato dal familismo nostrano, spesso può essere un vero inferno, come dimostrano le tante relazioni violente che lì si annidano; così come la piccola comunità civile non è garanzia di controllo e tutela dai soprusi verso i più deboli, in una visione tutta arroccata e chiusa di identità. Il problema quindi non è contrapporre il radicamento identitario alla globalità cosmopolita, o le famiglie tradizionali ad altri legami affettivi.
Il corpo ai tempi del nuovo coronavirus
Come cambierà la percezione del nostro corpo? Si accentuerà la tendenza già preponderante a viverlo staccato dalla mente e dai sentimenti (anche per effetto delle biotecnologie applicate alla vita e alla morte) o capiremo che raggiungere un’unità integrata delle varie parti della persona rende la vita più armoniosa oltre che difendere e curare più efficacemente il corpo stesso? Nella modernità liquida, il corpo sarebbe, secondo Zygmunt Bauman «l’unica certezza che ci rimane, l’isola d’intima e confortevole tranquillità in un mare di turbolenza e inospitalità… il corpo è diventato l’ultimo rifugio e santuario di continuità e durata… Da qui la rabbiosa, ossessiva, febbrile e nervosa preoccupazione per la difesa del corpo… il confine tra il corpo e il mondo esterno è una delle frontiere maggiormente vigilate e così gli orifzi corporei (i punti di ingresso) e le superfici corporee (i punti di contatto) sono oggi i principali focolai di terrore e di ansia generati dalla consapevolezza della mortalità, nonché forse gli unici». Fa riflettere rileggere queste righe scritte tanti anni fa mentre maneggiamo maldestramente le nostre mascherine per evitare che gli orifizi siano esposti al contagio. Il corpo sacralizzato come un santuario che custodisce un individuo-monade dentro una comunità-chiusa: è in questa serie di matriosche che si custodirebbe il simulacro di quella sicurezza identitaria che la liquidità aveva spazzato via e che ora, in un’epoca di possibili pandemie, sembra diventare una condizione normale e normativa. Il corpo, la sua cura, il suo benessere ci ossessionava, lo coprivamo di tatuaggi e lo coccolavamo, sempre più spesso come fosse una realtà a sé stante, staccato dalle altre parti di noi, dal nostro sé, dalla nostra mente e dal nostro cuore. Ora lo facciamo per necessità e sopravvivenza. Nella cultura giudaico-cristiana il corpo non va per conto suo, non è separato dall’anima o dalla mente. Solo un estenuato spiritualismo o un banale materialismo potrebbero affermarlo. Il cristianesimo è la negazione stessa di ogni possibile spiritualizzazione o idealizzazione. Sembra invece che, nella post-modernità, questa unità di mente-corpo evapori sempre di più, e che si fondi piuttosto sulla tecnica, la sperimentazione e la libertà fino a raggiungere una potenza tecno-scientifica che parcellizza ad esempio le varie parti del corpo femminile per ottenere una gravidanza (Sylviane Agacinski. L’uomo disincarnato. Dal corpo carnale al corpo fabbricato, Neri Pozza, 2020). E del resto, si sono moltiplicati, negli ultimi anni, gli studi che evidenziano come in questa crescente separazione tra mente e corpo si annidi l’origine delle diverse forme di fragilità della soggettività dell’individuo che invece avrà nel futuro post covid-19 sempre più bisogno di unità e di consapevolezza.
I diritti, la schizofrenia dell’Europa
Nelle settimane di lockdown mi avevano colpito due notizie apparentemente distanti: l’Ungheria aveva votato definitivamente contro la Convenzione di Istanbul, molto importante perché, per la prima volta, la violenza domestica in quel Trattato internazionale è considerata al pari della violazione di un diritto umano. La Convenzione è stata respinta con l’argomentazione che la patria potestà è intangibile in quanto deriverebbe da Dio. L’altra notizia veniva da Kiev, dove cinquanta neonati, partoriti da madri surrogate, erano fermi come “pacchi in giacenza” in un albergo di Kiev perché, causa nuovo coronavirus, le madri committenti europee non potevano andare a ritirarli. Una foto tristissima: sulla consunta moquette di un anonimo albergo si vedevano, allineate centinaia di culle con tanti neonati. Comprensibilmente concentrati sulle sorti di un’Europa in bilico per la grande crisi che ci aspetta, non dimentichiamoci però della sua fragilità anche sul piano dei diritti, che vede da una parte la completa libertà e dall’altra parte la negazione della stessa parità tra uomo e donna. Sul futuro dei diritti in Europa c’è una sorta di cupa eterogenesi dei fini che deve diventare l’occasione per riflettere sugli effetti di due grandi malintesi: da una parte una cultura, mascherata di cattolicesimo nazionalista, che finisce per usare l’identità come un randello rivelando la sua natura xenofoba e misogina e dall’altra una malintesa idea dei diritti che stravolge la stessa idea di libertà, che non è libertà, ma richiesta di diritto per fini egoistici e di interesse.
Per concludere ripenso al confronto serrato che abbiamo avuto con tanti colleghi e amici del Cortile dei gentili nei giorni del lockdown, nell’intrecciarsi di piani e discipline, tenute insieme, come ha detto bene il Cardinale Gianfranco Ravasi, da quella stessa resilienza trasformativa che ha mosso le nostre riflessioni. E allora è essenziale scegliere le priorità che, per la nostra Consulta, dovrebbero essere legate al tema della formazione e dell’educazione sia di una classe dirigente più preparata e sia di una istruzione di base per tutti, una postura, un atteggiamento che dovremmo tenere anche per promuovere quel “patto tra generazioni” che richiede certo conoscenza e ricerca ma anche maggiore senso di responsabilità.
di Emma Fattorini
Docente di Storia contemporanea presso l’Università La Sapienza