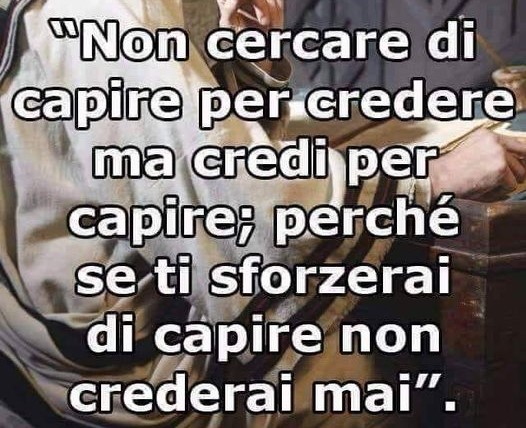Psicologia e vita cristiana-religiosa. Esperienza scomoda e difficile da gestire, la dimensione del nostro limite connaturale è un passaggio obbligato, l’unico terreno su cui può germinare e crescere la promessa evangelica di una vita piena.
Non è una pia esortazione, né una sorta di “ultima spiaggia” vista l’ineluttabilità dell’esperienza del nostro limite. Accettare la propria fragilità è qualcosa di più, un atteggiamento che segna un passaggio interiore, una “conversione” che affonda le sue radici nella parola di Dio. San Paolo ci ricorda che questo passaggio porta con sé qualcosa di molto profondo e vitale, addirittura qualcosa di mistico: «Ti basta la mia grazia: la forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza» (2Cor 12,9).
Non si tratta solo di una personalissima esperienza di Paolo, ma proprio di un tratto caratteristico del modo di procedere di Dio nella sua relazione con l’uomo. In un’altra delle sue lettere, infatti, Paolo ci ricorda che «Dio dimostra il suo amore per noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rom 5,8), come a dimostrare che a fare problema non sarà mai il suo atteggiamento di fronte alla nostra fragilità, al nostro peccato, ma il nostro.
Un’esperienza sempre scomoda
L’esperienza della nostra fragilità è spiacevole e difficile da gestire. Toccare con mano il nostro limite personale, sentire dentro la fatica, l’incertezza nel decidere, non saper come muoversi in circostanze percepite come troppo complesse per le nostre capacità… sono esperienze che non hanno soluzioni rapide, automatiche o definitive. La nostra fragilità ci fa sentire di volta in volta ansia, disagio, dubbio, insicurezza, rabbia, inferiorità, ribellione, confronto con gli altri e invidia… tutte emozioni poco piacevoli. Il fatto non si limita a qualche sporadica esperienza, marginale nel contesto della nostra esistenza quotidiana. Si tratta di una realtà con la quale ci confrontiamo sempre, ai più vari livelli: individuale, relazionale, comunitario, educativo.
A livello individuale, l’esperienza della fragilità è passaggio obbligato per tutti, tocca la questione dell’identità e del valore personale. Tutti noi abbiamo sperimentato, e sperimentiamo, dubbi – enormi durante l’adolescenza – circa la nostra dignità personale, il valore di essere fatti proprio così, con pregi e limiti del tutto caratteristici. L’essere unici è un privilegio, ma anche un peso e una grande responsabilità. A questo si aggiunge l’esperienza della fragilità relativa alla chiarezza personale in riferimento a un ideale, a un progetto di vita e alla coerenza con un chiaro sistema di valori. Vogliamo essere persone autentiche, tendiamo alla comunione nella comunità, vogliamo vivere il lavoro come un servizio, le relazioni con uno stile particolare: sono tutti desideri che dicono riferimento al mondo dei valori e al nostro Io ideale. E non sempre ci riesce di vivere ciò che desideriamo, secondo i grandi valori in cui crediamo. Tutto ciò si traduce in quella particolare percezione di sé che è la nostra stabilità emotiva e il senso positivo dell’Io, anch’essa sempre esposte alla fragilità.
A livello relazionale, l’esperienza della fragilità si presenta non appena si evidenziano le piccole o grandi differenze individuali. Abbiamo bisogni diversi, valori diversi, idee diverse, reazioni diverse di fronte alla realtà: una ricchezza di provocazioni che ci mettono in crisi, poiché scatta in noi un’immediata autovalutazione e un istintivo confronto con gli altri. Gli esiti di questa reazione possono essere diametralmente opposti, a seconda della maturità individuale: o si scivola meccanicamente in un atteggiamento di competizione – difensivo e poco utile – per decidere chi è il migliore, oppure si coglie l’occasione di questa diversità per valorizzarla, entrando in un atteggiamento di collaborazione responsabile in riferimento a un progetto comune, percepito come un’opportunità di crescita per tutti.
A livello comunitario, si avverte la propria fragilità proprio nel riconoscimento e nell’accoglienza della diversità dell’altro, con tutti i suoi limiti e le sue qualità. Quel che si diceva a proposito del livello relazionale trova applicazione anche qui, dove, si sa, si può scadere in atteggiamenti competitivi anziché cooperativi. Solo se si mantiene ben chiara una delle finalità della vita comunitaria – la consacrazione al Bene e alla crescita del fratello/sorella – sarà possibile vivere una vita comunitaria in cui la condivisione di un progetto carismatico e pastorale, e la fedeltà ad esso, sono il criterio che assicura la presenza di passaggi evolutivi utili al singolo e alla comunità. A livello educativo, cioè sul versante delle responsabilità educative ai più vari livelli, l’esperienza della fragilità può essere stigmatizzata nell’interrogativo: sto facendo bene? Chi me lo garantisce? A questo proposito, avere come punto di riferimento una visione antropologica che rispetti le caratteristiche e le aspirazioni fondamentali dell’essere umano è un utile elemento di discernimento.
Punti utili al discernimento
Per mettere in evidenza alcuni punti utili al discernimento, è bene vigilare su alcuni meccanismi relazionali sempre pericolosi. In generale, l’altro può a buon diritto essere oggetto delle mie attenzioni e del mio affetto, ma non deve mai essere vissuto come un prolungamento di sé. Un tale atteggiamento denuncerebbe un meccanismo di un’identificazione proiettiva, o un rapporto simbiotico col quale inconsciamente si mette a tacere l’ansia della propria insicurezza strumentalizzando l’altro, ma certamente senza promuoverne la crescita. Allo stesso modo, l’educatore è chiamato ad amare nella libertà, senza cioè legare l’altro a sé. Che significa? Vuol dire che anche l’amore può essere una strategia per esercitare un controllo, un modo per dominare l’altro… ed è proprio quel che bisogna guardarsi dal fare.
Il compito educativo è far crescere nella libertà. Tutti d’accordo, naturalmente, ma non è facile stare di fronte alla libertà di un’altra persona e al suo modo di usarla: subito ci sentiamo provocati dalla diversità, e l’esperienza della nostra fragilità fa scattare spesso strategie difensive che cercano di limitare la libertà dell’altro. Ci sono, infatti, dinamiche educative che fanno forza sul senso di colpa, un modo per piegare con il ricatto affettivo la volontà e la libertà altrui.
È bene ricordare, ancora, che l’opera educativa deve valorizzare l’intelligenza e il senso di iniziativa. Educare non è mai “addomesticare”. Non deve, cioè, favorire la dipendenza. L’educazione non si realizza con relazioni fondate sulla compiacenza, sul continuo riferimento a ciò che vuole o desidera l’educatore. Deve piuttosto aprire l’altro al coraggio nel prendere iniziativa, al gusto e alla pratica personale dei grandi valori della vita, di cui lo stesso educatore dovrebbe essere testimone. Insomma, più esempi che prediche! L’educazione è realtà esistenziale: dal nostro stile di vita gli altri, e i più giovani in particolare, dovrebbero poter cogliere il fascino e la gioia del Bene e desiderare di metterlo in pratica a loro volta.
Passaggio obbligato
Sentirsi fragili è un’esperienza legata alla nostra realtà umana. Non è una realtà sconveniente, e tantomeno una vergogna.
Nessuno può chiederci di essere onnipotenti, onniscienti, infallibili, eroi senza macchia e senza paura! Dio non lo fa, e certamente nessun altro può chiederci una perfezione impossibile.
La realtà è che siamo creature. Fragilità, crisi, errori, dubbi, fallimenti piccoli o grandi, limiti e peccati fanno parte del nostro bagaglio umano. Scandalizzarsene, far finta che non ci siano, giustificarli: sono tutte strategie che non eliminano la dura realtà di farne l’esperienza. Fanno parte della nostra natura e, ci piaccia o no, in qualche misura rimangono con noi per tutto il tempo della nostra vita.
Accettare di essere creature, con tutti i limiti e le ricchezze che ci caratterizzano, è un passaggio obbligato del nostro divenire persone, del cammino di crescita personale. Non accettare la propria fragilità comporta notevoli inconvenienti. Tra le altre cose, significa: temere il giudizio altrui, sentirsi sempre “sotto processo”, per cui gli altri diventano i miei “giudici”.
Non tanto perché lo siano realmente, ma perché io non accetto la mia fragilità. Significapercepire la diversità del confratello/consorella come una minaccia, e quindi il mio atteggiamento di fondo è quello difensivo. Significa interpretare il limite, la fragilità come inferiorità, come realtà di cui vergognarsi, perciò come qualcosa che devo nascondere, mettendomi maschere diverse a seconda delle circostanze.
Significa sentirsi inadeguati nel proprio ruolo comunitario e nella propria responsabilità educativa, e così trovarmi a vivere con troppa ansia l’essere consacrato/a e formatore, professore, pastore, ecc…
In definitiva, non accettare la propria fragilità significa temere la crescita, percepita come un sentirsi sempre messi in questione, in una sgradevole sensazione di spiacevole instabilità. Ma, a livello comunitario, comporta anche il non saper stare di fronte al cambiamento dell’altro, percepito come una minaccia, un’espressione di squilibrio, di scomoda asimmetria che genera ansia e crea un rimescolio generale nel mondo delle proprie insicurezze.
Fragilità e felicità
I due termini ci sembrano agli antipodi, in una condizione d’insanabile opposizione, non è vero? Se sei fragile non potrai mai essere felice, perche la felicità ci appare come quella condizione di pace e serenità a tutto tondo che non ammette zone d’ombra, limiti, difetti, incrinature. Se fosse davvero così vorrebbe dire che, purtroppo, non esiste alcuna persona felice…
Anni fa, Albert Camus scriveva: «C’è solo una disgrazia: quella di non essere amati. C’è una sola infelicità: quella di non essere capaci d’amare». Comprendiamo al volo la prima parte della citazione, un po’ meno la seconda che, probabilmente, avremmo completato come la prima. E invece siamo provocati dallo scrittore francese a pensare all’infelicità non come risultato di un qualcosa di bello che sfortunatamente non ci capita, ma come risultato di un qualcosa di bello che non permettiamo possa accadere a motivo della nostra incapacità d’amare, delle nostre tante paure, delle chiusure preconcette, delle continue lamentazioni. Perciò, non ci rimane che prendere coscienza del fatto che alla felicità bisogna lavorare continuamente, così come siamo e a partire da quel che siamo, cioè con tutta la nostra fragilità. Purtroppo, siamo debitori di una cultura in cui la valenza emotiva oggi ha raggiunto picchi di assoluta anarchia nel vissuto delle persone e dei gruppi sociali: un primato indiscutibile, ma insieme insensato e fuori da una reale logica di valore. Anzi, sembra che sperimentare emozioni forti sia diventato “il” valore irrinunciabile: la fonte che provoca tali emozioni non ha tanta importanza… un po’ come se la ciliegina fosse diventata più importante della torta! La vita, invece, ci insegna che il vero amore non è quello che si crede, magari seguendo la semplificazione in chiave sentimentale compiuta dai mass-media e dalla pubblicità. Nasce qualcosa di autentico e di nuovo quando qualcuno lo rende possibile con la propria disponibilità, con l’offerta di sé. Amare vuol dire aiutarsi, far di tutto per comprendersi, perché c’è ancora un’infinità di cose da conoscere e da comprendere circa la vita, il mondo, l’altro. Amare è dare la vita per il fratello, per diventare pienamente persone, trasfigurate dall’Amore.
Per poter ben educare
Fare i conti con la propria fragilità è un presupposto per essere un buon educatore. Infatti, educare significa doversi confrontare con i limiti, i difetti, le fragilità degli altri, e ciò comporta che noi si sia sufficientemente riconciliati con la nostra fragilità.
È necessario andare oltre quei meccanismi di difesa che facilmente scattano in noi quando ci troviamo esposti alla nostra fragilità: la negazione, che porta a dire «io non sono fragile!»; la proiezione, per la quale sembra logico che «… se sono fragile è tutta colpa di… (altri)!»; il fatalismo, per cui «che vuoi… essere forti è questione di fortuna!»; la razionalizzazione con la quale ci si giustifica sempre: «sì, è vero, ma…». Sarebbero tanti gli esempi che illustrano la nostra tendenza a non fare i conti con la nostra fragilità. Il ruolo educativo, invece, esige che un uomo e una donna abbiano affrontato decentemente la questione del proprio essere creature segnate dal limite. In caso contrario, come potranno stare di fronte all’esperienza del limite dell’altro? Come potranno essergli d’aiuto?
Un importante criterio della relazione educativa è questo: aiuti la crescita del tuo fratello se anche tu ti mantieni in atteggiamento di crescita. I valori dell’educatore sono il testimone da trasmettere alle nuove generazioni, più con i fatti che con le parole che, lo sappiamo, contano fino a un certo punto se non sono sostenute dall’esempio.
Il metodo con cui avviene questo passaggio è condividere i valori, forti di una esperienza personale, a volte proprio sofferta, accumulata nel tempo, il fine dell’impegno educativo è portare avanti tutti il compito fondamentale della vita: diventare persone autentiche. Obiettivo che, per noi, ha un senso specifico: diventare figli di Dio in pienezza, come Cristo. La sua croce, e il modo con cui l’ha vissuta, danno un significato rivoluzionario alla fragilità umana…